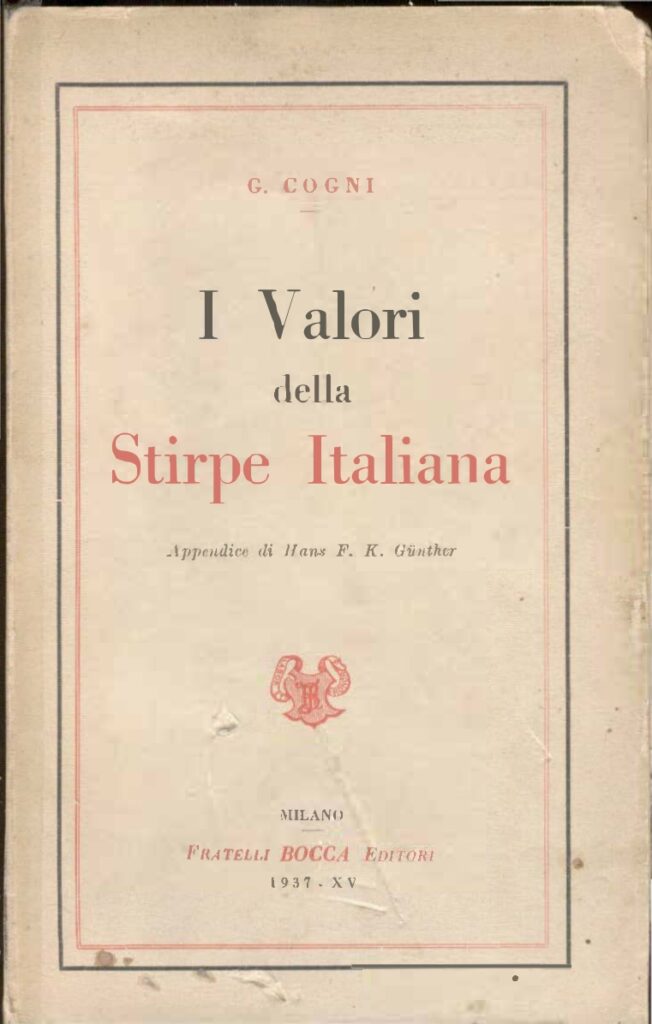di Piero Sella.
Questo eccellente saggio è stato pubblicato nel 2010, ma le situazioni che descrive e delle cui cause fornisce acute analisi, sono attuali oggi forse anche più di allora.
L’aumento esponenziale degli immigrati ha avviato nella società europea drammatiche trasformazioni. I nuovi arrivati, senza documenti, senza denaro e senza un mestiere, hanno trovato sistemazione accanto ai disadattati delle ondate precedenti. Ne sono nati insediamenti-ghetto a impronta geografico-razziale che stanno progressivamente lacerando il tessuto sociale. I bisogni, i desideri e le pretese di centinaia di migliaia di individui che non hanno un’occupazione e che sopravvivono sfruttati da gente priva di scrupoli, non possono che tradursi in illegalità.
In assenza di ogni serio controllo sanitario, amministrativo e di polizia cresce il degrado estetico e urbanistico: aumentano, di pari passo, furti, rapine e delitti. E’ una violenza di gruppo della quale la cronaca registra – con accettabile approssimazione – l’origine etnica. Negli assalti alle ville e nelle rapine si distinguono le feroci bande balcaniche. Le truffe e le risse tra ubriachi vedono prevalere i sudamericani, il traffico e lo spaccio di stupefacenti i nordafricani. Romeni e albanesi si occupano tanto della falsificazione di permessi di soggiorno e carte di credito che di reclutamento e sfruttamento della prostituzione.
Ma l’immigrazione è come un sasso gettato nell’acqua: i cerchi – i danni collaterali – si allargano e arrivano a toccare tutte le rive dello stagno, ogni settore della convivenza civile. Perdipiù, gli effetti negativi del fenomeno si manifestano anche quando la loro origine non è di tipo criminoso. E’ così per il mondo del lavoro, dove l’afflusso di concorrenti a basso costo penalizza economicamente gli autoctoni e altera l’intero equilibrio sociale.
La presenza del Lumpenproletariat extracomunitario spinge infatti quello nazionale verso gradini più alti. Scalzati dalle attività manuali dei livelli più modesti e dalle occupazioni artigianali, i giovani prolungano negli studi una spensierata adolescenza. Quando però giunge il momento di affrontare le scelte decisive della vita, la realtà cancella l’ottimismo delle attese. L’idea di una scalata della masse alle professioni liberali è pura utopia. E allora è fatale che i meno dotati vadano ad aumentare la disoccupazione intellettuale, il precariato, l’invidia e il disagio sociale. La democrazia fa da ammortizzatore: arruola legioni di questi nullafacenti e li piazza nelle sua nicchie parassitarie politiche, o nelle pletoriche amministrazioni statali e parastatali. Altri, nelle regioni meno ricche, s’arrangiano col lavoro nero o fanno carriera nella malavita organizzata. I più abulici troveranno stabile collocazione tra i disoccupati organizzati, ma grazie ai partiti arrotonderanno il sussidio con lo stipendio relativo a fantasiosi “lavori socialmente utili”. Fanno da salvagente anche le pensioni di invalidità elergite con larghezza da funzionari disonesti che gestiscono su larga scala il business del voto di scambio.
Evidente è anche l’impatto dell’immigrazione sulla scuola pubblica, ove la presenza di allievi che non capiscono la nostra lingua costringe intere classi a muoversi al passo dei più lenti. Lo Stato spende inutilmente i soldi dei contribuenti e i genitori che possono permetterselo trasferiscono i figli nelle scuole private.
Non diverso il caso della sanità, il cui bilancio è appesantito da un’assistenza estesa a chiunque è presente sul territorio dello Stato. Nel ricongiungimento familiare viene data addirittura la precedenza ai malati. Si arriva dunque in Italia, non per lavorare, ma per essere curati. E non basta, il ricongiungimento – così è stato deciso dalla Corte di Cassazione – deve essere concesso anche in caso di kafalah, una sorta di adozione islamica. Difficile risulta il mantenimento dell’ordine pubblico, affannoso il funzionamento della giustizia. Il peggio sono le carceri: oltre il 50% dei detenuti è costituito da stranieri, per alloggiare e sorvegliare i quali sono necessari sempre nuove strutture e l’impiego di migliaia di agenti. Occorre ammettere a questo punto che la colpa di quanto accade non è tutta degli immigrati. Molti europei, vittime di malsane influenze ideologico-culturali, ritengono che la presenza di milioni di stranieri e la mescolanza razziale che ne deriva non sia un male.
Agevolano così di fatto l’invasione. Un esempio di questa autolesionistica devianza è il capitolo dei matrimoni misti. Queste unioni, un focolaio di infezione razziale ormai fuori controllo – ben 34.000 casi all’anno – immergono puntualmente gli sprovveduti protagonisti e la loro disgraziata prole in una serie di guai senza fine. Le violenze, i sequestri di persona, i rapimenti dei figli vengono scaricati – è cronaca quotidiana – sulla collettività, con enormi spese e perdita di tempo per le forze dell’ordine, per la magistratura e persino per la diplomazia.
Un fenomeno di complicità all’invasione assimilabile ai matrimoni misti è quello delle adozioni internazionali. Anch’esso, con la crescita dei “diversamente bianchi”, produce effetti destabilizanti. L’Italia, grazie alle provvidenze economiche elargite dallo Stato al “genitori”, registra purtroppo il primato mondiale, oltre 4.000 casi all’anno, nelle adozioni di stranieri. Che lo strumento delle adozioni internazionali sia parte del progetto mondialista di generale imbastardimento è dimostrato dal recente intervento (28 aprile 2010) della Procura della Cassazione che, recependo una direttiva della Comunità Europea, ha censurato il comportamento di una coppia di Catania che aveva chiesto le venisse assegnato un bimbo di razza bianca, la stessa dei genitori. Voler scegliere è una deprecabile pretesa razzista.
Come reagiscono i partigiani dell’immigrazione di fronte all’inconfutabile elenco dei danni sociali ed economici, diretti e indiretti, da questa provocati? Continuano stucchevolmente a dipingerla da un lato come “indispensabile per la crescita”, dall’altro come “opportunità di arricchimento culturale”. Non rivedono insomma le loro posizioni; hanno addirittura l’impudenza di contrattaccare. Quando parlano di dialogo, di incontro, non esprimono la disponibilità a ridiscutere il problema coi connazionali di parere diverso, si riferiscono agli stranieri. Nonostante la crisi economica, i licenziamenti, la disoccupazione dilagante, si dànno da fare per rendere più agevole l’arrivo e la sistemazione di nuovi lavoratori extracomunitari.
Il Presidente Napolitano, di recente, a Bruxelles, ha spiegato che non può esserci discussione: chi non è per la globalizzazione, per la società multietnica, è fuori dalla storia, fuori dalla realtà. Il messaggio è chiaro: non si vuole più tornare indietro. La deriva razziale – buona o cattiva che sia – deve continuare; gli stranieri, i milioni di stranieri e i loro familiari sono ormai indispensabili; otterranno maggiori diritti, in primis, appena possibile, la cittadinanza. Attraverso queste concessioni – ci viene raccontato – cesseranno di odiare il Paese in cui vivono e i suoi abitanti, rispetteranno la legge, finiranno per integrarsi, gli zingari lavoreranno, i loro figli andranno a scuola, non ruberanno più. Corollario di queste banalità è la condanna più ferma nei confronti di chi preferirebbe non vivere circondato da gente estranea per razza e cultura; di chi insomma, per dirlo con chiarezza, è assolutamente convinto che il problema non sia quello dei clandestini ma quello, più vasto, dell’immigrazione. Queste posizioni, politicamente scorrette – a prescindere da quanto siano diffuse – vanno censurate, criminalizzate, soffocate.
Ma se il tentativo di dare sbocchi positivi alla società multietnica non produce – come abbiamo visto – altro che danni reali, se il progetto risulta solo un vaneggiamento utopistico, quali sono allora le ragioni che spingono l’oligarchia finanziaria dominante a perseverare nel suo ” errore”? Perché non si vuole prendere atto che la provenienza geografica, il colore della pelle, la fisiognomica, la lingua e l’educazione hanno costruito negli immigrati identità e visioni del mondo che non possono essere in alcun modo rimosse e perciò non possono combaciare con le nostre? Perché si respinge la logica conclusione che essendo l’identità e la concezione del mondo che ne consegue antropologicamente immodificabili, l’assimilazione risulta impossibile? Perché non si ammette che, in tale quadro, la qualità di “regolare” o “clandestino” del singolo immigrato, così come il suo titolo di studio, sono fattori ininfluenti? Che qualsiasi armonica, organica convivenza di gruppi umani diversi sullo stesso territorio è destinata a fallire? Che è fatale e ineludibile l’insorgere di reciproche diffidenze e ostilità? Non voler prendere in considerazione tutto ciò dimostra la pervicace volontà di puntare – costi quel che costi – a obiettivi ritenuti essenziali. Quali sono questi obiettivi? E’ semplice: non quelli fumosi, dolciastri e irrealizzabili che vengono reclamizzati, ma quelli, assai concreti, provocati dagli stessi danni. In una scala di valori capovolta essi sono le tappe ambite, previste e scandite nel tempo, di un progetto, quello demoplutocratico, che viene posto in atto grazie a una ragnatela mondiale di istituzioni autoreferenziali, non elettive, le quali devono render conto solo a chi le ha create e le tiene in vita.
Il disegno finale, da realizzarsi sulla pelle dei popoli attraverso la globalizzazione, è quello di un mondo nominalmente libero e democratico, reso di fatto snervato e omogeneo per consentire alla lobby atlantico-sionista di privatizzarlo. Per schiacciare ogni resistenza, la grande finanza ha mobilitato e messo a libro paga un esercito di persuasori che ha a disposizione tutti gli strumenti di formazione della opinione pubblica – editoria, cinema, televisione – e che si muove di concerto in tutti i Paesi della Terra. Ciascuno di questi, chi prima chi dopo, va colpito mercificando l’esistenza degli abitanti, eliminando, con campagne propagandistiche destinate a incidere sull’immaginario e sul costume, i legami di solidarietà etnica, culturale e sociale, i soli che possono garantire efficacemente la difesa della sovranità.
Il messaggio unico trasforma gli Stati in mercati, i popoli in masse indifferienzate di consumatori. Quel che rimane negli individui di altruistico è convogliato in direzione delle emergenze internazionali. Il cittadino democratico non ha più una patria, ma può, a comando, commuoversi, intenerirsi, mobilitarsi per la sorte altrui. Terremoti, naufragi, profughi da guerre civili, sono puntuali occasioni per accelerare l’accoglienza, il travaso, l’adozione di altri disperati. Non ha importanza se il più delle volte le emergenze sono provocate dagli stessi che le sfruttano: le vicende della Palestina, del Kosovo, dell’Iraq e dell’Afghanistan [e, aggiungiamo, le vicende della Libia dopo l’aggressione franco-anglo-americana] non dicono nulla alle masse.
L’informazione è distorta, la gente non legge e non riflette, abbocca e si adegua, i pochi cervelli pensanti si rendono conto che ogni spazio di libertà è precluso. Le idee che si ribellano al dogma multirazziale liberalcapitalista sono percepite come bestemmie, equiparate allo psicoreato, condannate all’ostracismo. Nessuna forza politica antagonista, espressione autentica dello spirito dei popoli, può sperare di affermarsi quando le masse sono bloccate in un luogo diverso. E’ questa la situazione che si è determinata con l’infausto esito del secondo conflitto mondiale e che da allora condanna l’Europa alla sudditanza; prima nei confronti delle due Superpotenze vincitrici, Usa e Urss, poi, con il crollo dell’Unione Sovietica, dei soli Stati Uniti, i quali vogliono imbalsamare l’Europa nelle strutture della NATO per impedirle ogni iniziativa autonoma in tema di politica internazionale. In particolare, per quanto riguarda Vicino e Medio Oriente, dove l’Europa è costretta dagli atlantici a condividere le posizioni filosioniste.
Quegli stessi persuasori occulti che, al servizio dei guerrafondai occidentali si erano inventati “le armi di distruzione di massa” irachene, agitano oggi la minaccia del terrorismo e dell’atomica iraniana. Ma lo sforzo maggiore della cupola internazionalista è oggi quello finalizzato a balcanizzare l’Europa.
Lo tsunami migratorio è stato individuato come lo strumento più adatto. Più minoranze ci sono, più il vecchio Continente risulterà instabile. Alla fine dovrà somigliare a una Jugoslavia su grande scala, privo di compattezza etnica e di tradizioni condivise. L’Europa sarà tenuta in permanenza sull’orlo della guerra civile, una guerra già latente fra i vari gruppi razziali. E’ la debolezza auspicata e orchestrata da chi vuole giustificare la supervisione politica ed economica del mondialismo e la spada di Damocle dell’intervento umanitario.
Ma quanto sopra argomentato non appare sufficiente a spiegare il successo dei nemici dell’Europa e le difficoltà incontrate da chi ha capito la strategia mondialista e vuole battersi per bloccare e invertire l’attuale deriva anti-identitaria. A minare la resistenza contribuisce in modo sublimale, ma determinante, la religione. La “compassione cristiana”, la spinta verso un generico amore universale, si traduce infatti nella proposta da parte della Chiesa di un modello di umanità privo di connotazioni nazionali e razziali. Comprendiamo benissimo il fatto che l’azione della Chiesa nasce da una visione spirituale tesa verso il bene; oggi però lo sforzo risulta controproducente, perché va a confondersi, a inglobarsi col disegno rapace e irrispettoso dell’uomo perseguito dall’oligarchia atlantica. Nei secoli passati la disponibilità del clero all’aiuto, all’assistenza, si indirizzava ai poveri, ai malati, agli orfani della parrocchia, del paese, o tutt’al più della regione. Erano azioni solidali circoscritte, che non uscivano dai limiti geopolitici della comunità. Si trattava dunquedi interventi non solo eticamente apprezzabili, ma di indubbia utilità sociale.
Il declino della potenza europea, la sostituzione del colonialismo con l’imperialismo economico, l’esplosione demografica della popolazione mondiale provocata dall’azione antiselettiva della medicina, il disastro dell’Africa vittima della corruzione, delle monoculture e delle guerre tribali, hanno condotto a un’emergenza generale nella quale i bisognosi non sono più casi isolati, ma sono decine di milioni.
La Chiesa ha affrontato impreparata un simile cambiamento, ha solo pensato ad allargare, per quel che poteva, il suo intervento assistenziale; non ha afferrato la gravità del problema, le devastanti implicazioni, la responsabilità di trasformare – agevolando l’arrivo e l’inserimanto degli stranieri – l’Europa, in pochi decenni, in una società miltietnica e multireligiosa. Quello stesso altruismo che nel passato era la fisiologica applicazione della dottrina favorisce oggi l’ingresso destabilizzante degli stranieri e il meticciato. Quando la Chiesa si batte perché gli immigrati siano equiparati – addirittura anteposti – nei diritti, agli autoctoni la sua solidarietà assume caratteristiche anarchiche. Con questa forzatura, il cristianesimo fa proprie le caratteristiche eversive dell’internazionalismo marxista. Diventa comunismo, si mette addirittura in gara per superarlo. Nell’Unione Sovietica, infatti, il partito unico, nonostante i suoi demagogici proclami ugualitari, non era mai giunto a mettere le nazionalità associate sullo stesso piano dell’etnia russa.
L’azione della Chiesa costituisce insomma non una tutela, ma una minaccia per l’esistenza dei popoli europei. Questi, se un tempo ritenevano meritorio aiutare i religiosi nelle loro opere assistenziali, oggi soppesano lo stesso tipo di partecipazione con diffidenza. Senza regole, senza un preciso criterio-giuda gli interventi sono peggio che inconcludenti, possono risultare dannosi.Come insegnano il cuoco col sale e il guastatore con l’esplosivo, è proprio il quantum, la misura, a dare senso ed equilibrio al fare. La Chiesa oggi mostra purtroppo di disprezzare la volontà del suo popolo di rimanere se stesso, condanna chi cerca di respingere l’assalto che la finanza mondialista conduce attraverso l’immigrazione, declassa il nazionalismo, l’amor di patria, a deprecabile xenofobia. Spingendo le vittime dell’invasione a non reagire, a subire passivamente, addirittura a collaborare, la religione si pone di fatto fra gli ausiliari dei poteri forti. E’ superfluo sottolineare quanto tale orientamento torni utile ai nemici dell’Europa. Il contributo non proviene infatti da ambienti politici o economici interessati, ma da un potere spirituale, ufficialmente imparziale, cui le masse attribuiscono da sempre grande autorevolezza.
Lo schieramento della Chiesa non potrà restare senza conseguenze: la secolarizzazione dei Paesi europei (Galli della Loggia nel Corriere della Sera del 21 marzo 2010 parla di scristianizzazione) e il calo delle vocazioni dipendono, e sono quindi destinati ad aggravarsi, dal progressivo allontanamento della religione dai legittimi, vitali interessi dei fedeli. La Chiesa, incredibilmente, non si oppone neppure alla formazione in Europa di minoranze religiose, e ciò anche se dovrebbe essere evidente il rischio per la convivenza civile se sul medesimo territorio sono installati, e si mettono in concorrenza, più monoteismi, tutti ovviamente con pretesa di essere l’unica verità. Già David Hume, nel Settecento, metteva in guardia contro questo pericolo consigliando i politici saggi di appoggiare e mantenere un’unica organizzazione religiosa e reprimere tutti i suoi avversari. Pare un controsenso, ma a volte sono i laici a capire meglio degli ecclesistici quale può essere l’interesse della Chiesa. Un interesse che forse in futuro potrà essere meglio tutelato da chiese nazionali.
Per comprendere l’attuale posizione della Chiesa sul’immigrazione, è necessario un breve escursus storico. A partire dalle sue origini, e per lunghi secoli, il cristianesimo si era allontanato dalle sue radici, dal contesto medio-orientale-giudaico in cui era nato, per conformarsi al luogo di adozione, Roma. Era diventato europeo e imperiale, aveva recuperato e fatti propri miti popolari e forme religiose della classicità. Al monoteismo, esclusivo e intollerante, aveva aggiunto il culto di figure comprimarie “specializzate”, assimilabili ai semidei del paganesimo.
Ma il papato si era anche laicizzato, partecipando da protagonista alla grande politica. Aveva organizzato alleanze, crociate, era giunto a condizionare il potere degli Stati e delle grandi monarchie. Nel Rinascimento, epoca della grande espansione europea, si può parlare, senza tema di esagerare, di simbiosi, di reciproci vantaggi che cristianesimo e potenze coloniali traggono dalle conquiste, dall’occupazione e dall’evangelizzazione di nuove terre in Asia, Africa e America.
Ricordiamo qui, per inciso, le funeste conseguenze cui vanno incontro i gruppi umani oggetto dell’evangelizzazione, del tentativo di esportare la religione. I convertiti e i loro ignari discendenti entrano puntualmente in conflitto coi compatrioti rimasti fedeli alle antiche credenze. E’ questo il meccanismo per cui i cristiani, in Nigeria o in India, vedono oggi le loro case e le loro chiese bruciate, le loro stesse vite messe in pericolo. A chi, per debolezza o opportunismo, si sia accostato alla religione del conquistatore, non resta che un’unica via d’uscita, una grigia vita da rifugiato in un luogo dove la religione adottata non è sufficiente a farlo accettare.
Con la fine del potere temporale e la laicizzazione della società la Chiesa nell’ultimo secolo del millennio passa sulla difensiva, cerca di conservare i suoi privilegi e la propria autorità spirituale allineandosi alla politica delle grandi potenze. Mentre le missioni protestanti anestizzano le popolazioni dei grandi imperi coloniali assimilandole alla visione occidentale del mondo, il Vaticano si adegua alla fascistizzazione dell’Europa, firma concordati con l’Italia e la Germania, esprime il suo consenso alla conquista dell’Etiopia e all’intervento antibolscevico in Spagna.
Il Mein Kampf di Hitler, il testo di riferimento della Rivoluzione Nazionalsocialista, non viene messo all’indice; ma ancor più significativa appare la sostanziale accettazione delle leggi di Norimberga sulla razza (1935) e quelle italiane (1938). In questo contesto il Vaticano si limita a difendere i suoi; mette in atto una difesa settaria che si accontenta di vedere riconosciuta la propria autonomia giurisdizionale in fatto di conversioni, battesimi, matrimoni.
Se, come abbiamo visto, la religione non attraversa la storia senza interagirvi, è logico che con la fine del secondo conflitto mondiale tutto debba cambiare.
La due Superpotenze, Usa e Urss, spartita l’Europa, danno vita alla politica dei blocchi – Nato e Patto di Varsavia – e governano il mondo attraverso istituzioni politiche addomesticate. A Washington e a Mosca guidano la danza gli uomini dell’usura internazionale. Ed ecco Russia e America battersi alle Nazioni Unite per la causa sionista, essere le prime due nazioni a riconoscere lo Stato ebraico. In tale nuova realtà la Chiesa deve farsi perdonare il precedente orientamento, una neutralità che più volte si era mostrata fortemente preoccupata per l’idilio antieuropeo tra democrazia e comunismo.
Il riequilibrio è radicale e traumatico. Subentrano, con la morte di Pio XII, gerarchie appartenenti alla fazione giudeizzante. Si tratta, si discute, vengono riesaminate con occhio diverso questioni teologiche chiuse da secoli, ma sempre pronte a riesplodere all’interno di un monoteismo imperfetto. I nuovi rapporti di forza, determinati dalla vittoria militare della coalizione giudaica, mettono in crisi la diarchia tra Jahveh e Gesù. Si può parlare di una vera e propria restaurazione. Il Dio del Vecchio Testamento è rimesso, dai suoi fidi, al vertice. E’ la nemesi-vendetta per il colpo di stato che lo aveva detronizzato due millenni prima, a favore del Figlio. La “Nuova Alleanza”, aperta dalla Chiesa di Roma a tutti i popoli della Terra, alleanza che aveva unilateralmente obliterato l’originale “Patto” tra Dio ed il “popolo eletto”, appare a questo punto una precipitosa fuga in avanti, una ripicca dettata da quanto era accaduto – la corresponsabilità, fino ad allora indiscussa, degli ebrei alla crocifissione – la parola di Dio, l’elezione di Israele, non avrebbe mai dovuto essere messa in discussione.
Si cerca insomma di ricondurre, con il minimo di scosse, l’eresia cristiana nel filone dell’ortodossia giudaica. Nella Chiesa cattolica torna così ad avere cittadinanza la visione minimalista e razzista di un dio tribale che offre protezione ai soli ebrei. A favore dei quali interviene nella Storia, promettendo la conquista di territori su cui essi non hanno alcun diritto, individuando per loro i nemici da colpire, incitandoli alla guerra e alla pulizia etnica contro i vinti. Il Cattolicesimo, che con un salto di civiltà, aveva degiudaizzato e universalizzato il monoteismo, accetta di reinterpretarsi. Rinuncia a credere che la salvezza può discendere solo salla fede in Cristo; la Verità non più unica. Invece di convertire i giudei, è la Chiesa di Roma ad offrire al Dio ebraico i milioni di fedeli mobilitati in nome di Gesù. Forse non saranno del tutto graditi, in quanto “gentili”, esseri di serie B, ma in ogni caso Jahveh non aveva mai avuto tanta gente ai suoi piedi.
Il dialogo tra le due religioni risente di questo clima di sudditanza. I pontefici sono accolti in Sinagoga, dove chiedono perdono agli ebrei per le colpe della Chiesa. Il giudaismo non ha nulla di cui pentirsi, sorvola sulle questioni spirituali e teologiche, sulle quali non può che essere in disaccordo, e incalza i cattolici. I rabbini non si accontentano di revisioni parziali, fanno leva sul riavvicinamento cristiano alle fonti veterotestamentarie per cogliere risultati concreti, per parlare di affari, in primis del diritto ad esistere dello Stato ebraico.
Il Vaticano si destreggia a lungo, ma il segno della resa sono i pellegrinaggi dei suoi papi nella Gerusalemme occupata dall’esercito ebraico e le umilianti visite al museo della Shoah. La Chiesa, accettando di porre le proprie radici nella cosmogonia ebraica, non può negare né il “Patto” né la collegata “Promessa”; riconosce come valida legittimazione dello Stato ebraico, le leggende raccolte e gonfiate nella Torah degli scribi ebraici. Mentre si rinnegano le Crociate della cristianità, si avalla la conquista della Terrasanta da parte dei giudei.
Il riconoscimento di Israele da parte del Vaticano ha però ripercussioni pratiche di eccezionale gravità politica. E’ il coinvolgimento pieno del cattolicesimo post-conciliare nell’avventuroso azzardo dell’imperialismo sionista. La Chiesa prende insomma in modo eticamente inaccettabile le parti dell’unico colonialismo rimasto sulla Terra e interviene in prima persona nella guerra di civiltà scatenata contro l’Islam dai sionisti e dalla lobby ebraica che sovrintende all’Occidente atlantico. Roma finge di non sapere cosa sta accadendo al Popolo palestinese, chiuso da reticolati, muri di superficie e sotterranei (che a Gaza, sul confine egiziano, raggiungono quota -20 metri). La celebrata diplomazia vaticana, invece di muoversi per la pace, dà forza ai guerrafondai e all’ingiustizia. Per quel che riguarda l’Europa , la allontana da quella politica di autonomia e non intervento negli affari altrui che può assicurare proficui, pacifici rapporti commerciali, energetici e turistici con il vicino mondo arabo e musulmano. Ma la Chiesa espone anche la vita dei suoi fedeli al rischio di sanguinose ritorsioni di tipo terroristico. Ci pare calzante, a tale proposito, una frase di Alessandro Manzoni: “I provocatori, i soverchiatori, tutti coloro che, in qualunque modo, fanno torto altrui, sono rei, non solo del male che commettono, ma del pervertimento ancora a cui portano gli animi degli offesi“.
Ma se l’involuzione veterotestamentaria ha portato la Chiesa a schierarsi in una disputa internazionale a fianco di un contendente eticamente e istituzionalmente impresentabile qual è lo Stato ebraico, questo stesso ritorno alle antiche radici l’ha spinta, sul tema immigrazione, a scelte disastrose per la vita dei popoli europei.
A spiegare la scivolata ci sono, ancora una volta, il Patto e la Terra Promessa. L’accostamento tra quella destinata agli ebrei, la Palestina, e quella destinata agli extracomunitari, l’Europa, sembra infatti, per i cattolici, inevitabile, addirittura rispettoso dei parametri della giustizia distributiva. Dando semaforo verde alle due Terre Promesse, la Chiesa fonde integralismo giudaico e compassione cristiana. Sembra ad essa essere coerente e meritorio – tanto in un caso che nell’altro – dare una mano a gente in cerca di sistemazione in casa altrui.
Non c’è del resto da stupirsi che favorisca l’invasione, agevoli la strategia di penetrazione di masse di razza, cultura e religione diverse, chi nel proprio DNA – nelle radici – conserva la positiva, ammirata valutazione di un evento dello stesso tipo, un evento – l’originale stanziamento ebraico in Palestina – assolutamente centrale, fondante nella costruzione religiosa giudaico-cristiana. Lo è tanto che il Libro lo attribuisce addirittura ad una volonta sovrannaturale. E’ infatti Dio stesso che di continuo (nel senso che il messaggio è ripetuto in modo ossessivo) incita il suo piccolo popolo, i primi nomadi ebrei capitati non si sa come in Palestina, a farsi numerosi come le stelle, per poter soverchiare gli autoctoni e trasformarsi da forestieri appena tollerati, in padroni del Paese che li ospitava.
L’obiettivo è ambizioso, ma come può essere còlto? Come potranno gli ebrei organizzarsi, restare uniti, irrobustirsi, preparare con prospettive di vittoria la Guerra Santa contro i loro vicini, più numerosi e più forti? (1)
Certo è un piano a lunga scadenza, ma la parte più significativa della Torah contiene tutte le indicazioni necessarie per relizzarlo. E’ Dio stesso a fornirle; si tratta di una serie di prescrizioni comportamentali fissate con il carattere di assoluta inderogabilità, le quali, una volta assimilate e trasmesse ai discendenti, costruiranno a protezione del popolo ebraico una invisibile ma salda barriera di fanatismo integralista. Un fanatismo che, presso qualsiasi nazione viva, tiene l’Eletto separato dal resto della popolazione. In tutti i momenti della giornata, dalla fanciullezza alla vecchiaia, gli sono preclusi, se non finalizzati a lucrose transazioni, i contatti con la gente del Paese, i non eletti, giudicati impuri.
Tutto ciò lo mette al riparo dal peggiore dei rischi, quello di venire assimilato. Il massimo della sicurezza, il luogo ideale dove assolvere senza fastidi tutti i complicati obblighi previsti dalle regole di una setta a base razziale, è però il ghetto. Lì la vicinanza coi correligionari, con chi ha le stesse abitudini, rende sopportabile all’ebreo una vita che, fuori, lo porterebbe quanto meno ad essere dileggiato.
E’ di grande interesse antropologico e politico rilevare come la strategia ebraica di penetrazione in Palestina disegnata dalla Torah abbia grande anologia con quanto accade oggi in Europa con gli immigrati islamici. Non deve stupire che le direttive seguite da queste minoranze per preservare la loro identità in vista dello scontro finale siano simili. Stesso dio, stessa ricetta.
Nulla resta fuori dal loro raggio d’azione: sono imposti la circoncisione, il divieto di matrimonio con estranei al gruppo; sono elencati precisi divieti circa l’alimentazione e la cottura dei cibi; sono fissati riti particolari e giorni di riposo sfalsati da quelli della maggioranza.Ma soprattutto è prescritto un codice di comportamento sfrontatamente incentrato su una doppia morale, ossia imperniato su regole variabili a seconda che l’interlocutore sia un appartenente alla setta o un estraneo.
Quanto gli ordini forniti dalla divinità siano solo apparentemente cervellotici e risultino invece funzionali a garantire attraverso l’apartheid la conservazione del gruppo è dimostrato dal grado di inassimilabilità conservato nei secoli dalla diaspora ebraica. Un paio di episodi confermano quanto l’osservanza di tali regole sia ancora oggi radicata. Pochi giorni fa un cliente, acquistato un branzino, ha chiesto al mio pescivendolo di pulirlo e squamarlo. Ottenuta la disponibilità, estraeva dalla borsa il coltello di sua proprietà col quale pretendeva fosse eseguita l’operazione. Al negoziante allibito spiegava che, essendo ebreo, doveva rispettare la regola – la kasherut – sulla purezza degli alimenti. Un conoscente mi ha invece riferito che nel suo locale, prenotato per un matrimonio ebraico, il rabbino e i suoi assistenti si sono presentati di buon mattino per lavare e disinfettare i frigoriferi e tutta l’attrezzatura di cucina.
Ma queste prescrizioni “religiose” che “incapsulano” il gruppo, oltre a essere una vera e propria guida tecnica per l’invasione delle nazioni, consentono anche a queste minoranze, restando divise (dagli altri) e colpendo unite (gli altri), di conquistare a vantaggio dei singoli e della comunità una quota rilevante di posizioni di potere. Un solo dato, riguardante la diaspora giudaica nordamericana: col 2% della popolazione degli Usa, agli ebrei sono stati finora attribuiti il 37% degli Oscar per la regìa e il 51% dei premi Pulitzer per il giornalismo. Risultati di questo livello sono comuni a tutti i Paesi in cui esiste una minoranza ebraica; e questa è lì perché ha giudicato di poterli conseguire; si tratta di minoranze attive ed ambiziose abituate da secoli ad operare in ambienti da loro stesse ritenuti pregiudizialmente ostili. Da questa realtà conseguono atteggiamenti guardinghi e permalosi. La suscettibilità giudaica è sempre pronta a lanciare accuse, a lamentare presunte mancanze di rispetto, a sollevare eccezioni, a chiedere, a risarcimento del pregiudizio antisemita, riguardi particolari.
Ma la minoranza non cerca solo di sopravvivere e di procurarsi favori. C’è anche una strategia di attacco che punta a mettere in crisi i valori etici e politici del Paese preso di mira. Giovanni Sartori, sul Corriere della Sera del 5 gennaio 2010, sostiene a questo proposito una curiosa tesi: “Le minoranze ebraiche mantengono nelle odierne liberaldemocrazie la loro millenaria identità religiosa e culturale, ma al tempo stesso, risultano perfettamente integrate nel sistema politico nel quale vivono”. E’ vero – rispondiamo a Sartori – ma ciò avviene unicamente nelle liberaldemocrazie. regimi nei quali l’ebreo è riuscito a plasmare i valori etico-politici della nazione che lo ospita secondo i suoi più ottimistici desiderata.
Quel che il musulmano sogna di conquistare con la sharia, gli ebrei l’hanno già ottenuto, prima con il giudeo-cristianesimo, poi col giudeo-bolscevismo, oggi con la democrazia, per loro il migliore dei mondi possibile.
Come il giudeo-cristianesimo favorisce con le proprie strutture ecclesiastiche la deriva verso la mescolanza razziale e il giudeo-bolscevismo punta attraverso l’ideologia marxista a disgregare i popoli con la lotta di classe, così la democrazia si batte contro il Volk, la comunità, e tenta di soffocare ogni pulsione nazionalista. Il gruppo ebraico ha saldamente in pugno tutti questi tre ingannevoli, distruttivi marchingegni. Non li teme, perché è certo, maneggiandoli, di non trarne alcuna ricaduta dannosa: la sua robusta, collaudata corazza razzista lo pone infatti al riparo dal fuoco amico.
Quale migliore prospettiva, in conclusione, per le minoranze straniere che stanno mettendo le basi per l’invasione o comunque per la loro supremazia, di una religione e di una classe sacerdotale che, nel paese da infiltrare, predicano e praticano l’accoglienza senza limiti e la giudicano gradita a un dio? Di una vera e propria quinta colonna che impedisce di considerare l’invasore diverso e di respingerlo in quanto ostile. Queste posizioni, in aperto conflitto con la volontà dei popoli di battersi per la propria esistenza, sono alimentate dal velenoso miscuglio contenuto nelle radici giudaico-cristiane. L’adesione a queste stesse radici è sfruttata dai politici democratici per ingabbiare i popoli in istituzioni estranee alle basi classiche e moderne del pensiero europeo. Ma il tentativo può essere neutralizzato, l’antitodo esiste ed è già stato più volte collaudato.
Tratto da “l’Uomo libero” n. 69, 2010
——————————
(1) Domande legittime al tempo della stesura dell’articolo; oggi abbiamo la risposta: con l’integralismo e il fanatismo, certo, ma soprattutto con l’incondizionato appoggio politico, economico e militare dell’Occidente, in primis gli Usa, i cui governi, direttamente o indirettamente, essi controllano e dirigono (n.d.r.).